Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna chiedono poteri maggiori in una grande quantità di materie, dalla sanità all’istruzione
Ernesto Galli Della Loggia Corriere della Sera 14 febbraio
Sta arrivando sul tavolo del governo il piatto con la patata bollente della richiesta da parte di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – suffragata da un referendum popolare che si tenne l’anno scorso – che si dia contenuto concreto alla cosiddetta «autonomia regionale differenziata». In pratica la richiesta di un ulteriore ampliamento dei poteri delle tre regioni suddette a cui si prevede che presto si accoderanno (anche se probabilmente con richieste di minore portata) pure Piemonte, Liguria, Toscana,Umbria e Marche.
La richiesta di maggiori poteri riguarda una gran quantità di materie ed è di tale misura da sancire di fatto, tra l’altro, la fine del servizio sanitario nazionale e del sistema nazionale dell’istruzione, il potere di veto delle regioni sulla realizzazione delle infrastrutture, la parcellizzazione delle normative in tutta una serie di ambiti, dai beni culturali all’ambiente, e infine, nonché, cosa d’importanza decisiva, la proporzionalità del finanziamento dei servizi sociali di ciascuna regione al suo gettito fiscale.
In pratica — ed è questa che conta, contano i fatti e le loro conseguenze effettive, non le formule tortuose con le quali si può sempre nascondere la verità e far credere qualcos’altro — se tutte queste richieste o anche solo la loro parte più importante fossero accolte, a più o meno breve scadenza l’intero Centro-Nord della Penisola diventerebbe un Paese a sé. I cui cittadini avrebbero la possibilità di godere di una certa qualità di scuola, di assistenza sanitaria, di trasporti, di tutela ambientale; mentre quelli della parte della Penisola dal Lazio in giù disporranno invece di queste medesime cose ma di una qualità assai diversa. Inutile dire quale delle due presumibilmente la migliore.
«Ma non è forse già così ora?» si può obiettare. Certo. Ma proprio questa constatazione suona come la critica più radicale al regionalismo italiano in generale e in particolare alla motivazione di cui esso continua ancora oggi a farsi forte, vale a dire che l’ordinamento regionale lungi dall’indebolire l’unità del Paese rappresenterebbe anzi un’occasione per la sua maggiore unità. L’esperienza dimostra che ciò è falso. Da tutti i punti di vista oggi, dopo mezzo secolo di regionalismo reale, il Sud nel suo complesso è sempre di più un’altra Italia rispetto al Centro-Nord. E naturalmente nulla permette di credere che l’autonomia regionale differenziata non accrescerebbe il divario esistente.
La causa immediata del divario sta a mio giudizio nel fatto che dopo l’approvazione della riforma dell’articolo V della Costituzione – voluta a suo tempo da un centrosinistra vile, disposto a tutto nell’illusione di poter in tal modo guadagnarsi un futuro – l’ordinamento non prevede, tranne casi eccezionalissimi, alcuna forma di controllo e di sanzione effettiva da parte dell’autorità centrale sull’attività interna delle regioni, sul modo in cui esse vengono amministrate dai loro rispettivi governi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: poiché l’Italia è quella che è, ciò ha significato puramente e semplicemente lasciare le regioni del Mezzogiorno e il meccanismo del loro consenso politico nelle mani – mani grazie al regionalismo ancora più forti e dotate di maggiori risorse rispetto a prima – di gruppi dirigenti inetti e spesso moralmente opachi. La verità è che l’esistenza dell’ordinamento regionale ha potentemente contribuito a murare le società meridionali nel carcere della loro storia antica fatta di arretratezza ma soprattutto di assenza di qualunque tradizione di buongoverno. Le ha perlopiù riconsegnate al dominio di consorterie politiche rotte a tutte le pratiche di sottogoverno e capaci di autoperpetuarsi all’infinito grazie al cambio di casacca e al voto di scambio: quel dominio che invece lo Stato nazionale e il circuito progressivamente ampio del suo sistema politico provvedeva almeno in parte a limitare e correggere. Con il regionalismo, in conclusione, il Mezzogiorno ha perduto qualunque posto e voce sulla scena nazionale ed è ripiombato in una solitaria impotenza.
Ma la sua è un’impotenza che a ben vedere non fa altro che rispecchiare l’impotenza storica del regionalismo del Nord, che poi in realtà è stato solo un regionalismo lombardo- veneto. Cioè di un regionalismo che in questo dopoguerra non ha saputo presentarsi che come pura e semplice rivendicazione della diversità, e come richiesta altresì di tutela dei vantaggi che innanzi tutto la storia e la geografia hanno assegnato a tale diversità: dal momento che se le provincie, mettiamo, di Treviso o di Como sono più ricche, più attrezzate e più sviluppate, di quelle di Benevento o di Matera il merito, forse, non è solo delle loro pur laboriose ed encomiabilissime popolazioni bensì delle condizioni favorevoli delle loro produzioni agricole, dell’agevole accesso ai mercati, del facilità del sistema viario, della vicinanza all’ Europa, ecc, ecc.
Sta di fatto che a differenza della grande tradizione di tipo federalista, nel Dna del regionalismo nostrano (in cui non a caso brilla la vistosa assenza del Piemonte) non c’è mai stata alcuna visione statal-nazionale, alcun tentativo di tener conto della specifica complessità e varietà del nostro Paese. Più che pensare qualcosa come uno Stato pluriregionale ma unitario, capace di tenere insieme le diversità evitando però il pericolo dell’autoreferenzialità delle sue singole parti, ci si è accontentati e ci si accontenta assai più prosaicamente di reclamare da parte dei più ricchi e sviluppati la massima mano libera nei confronti dello Stato centrale.
Uno Stato che non a caso viene di fatto concepito in termini per così dire puramente residuali, mentre per quanto riguarda l’Italia come nazione l’impressione è che ormai essa sia sentita più che altro come un’imbarazzante e inutile mitologia.


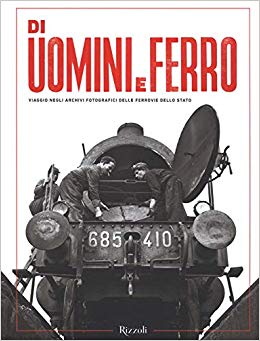 Di uomini e ferro
Di uomini e ferro